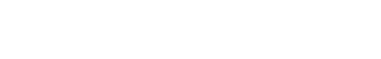Il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di un interesse legittimo,
oggi implicitamente ammesso anche dal legislatore ordinario che, con
l'art. 7 della legge n. 205 del 2000 ha previsto che il G.A.,
nell'ambito della sua giurisdizione generale di legittimità ha
competenza anche per i conseguenti profili risarcitori, ha trovato
definitivo ingresso nell'ordinamento giuridico a seguito della sentenza
n. 500 del 1999 delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione.
In precedenza il risarcimento del danno per la violazione di un interesse legittimo era escluso dalla giurisprudenza per motivi di ordine processuale in quanto il G.A., competente a giudicare in materia di interessi legittimi, poteva esclusivamente disporre l'annullamento dell'atto lesivo ma non il conseguente risarcimento del danno ed in quanto il G.O., che aveva il potere di disporre la condanna al risarcimento del danno, non aveva, però, competenza a giudicare in ordine all'interesse legittimo.
Ma il risarcimento del danno derivante da lesione di interesse legittimo era, ancor prima, escluso per ragioni di carattere sostanziale in quanto, nel modello della tutela aquiliana di cui all'art. 2043 cc, il danno ingiusto veniva fatto coincidere con la lesione di un diritto soggettivo o , in ogni caso, di una situazione giuridica protetta direttamente da una norma giuridica preesitente, con la conseguente esclusione, dall'ambito della sua tutela, della lesione di diverse posizioni giuridiche come, per l'appunto, quella costituita dagli interessi legittimi la cui lesione consegue ad una violazione di una norma sull'agere dell'amministrazione e non già di una norma posta a presidio diretto degli interessi legittimi.
La giurisprudenza ha, poi, temperato la propria posizione contraria al
risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo elaborando la
figura del diritto affievolito
e riconoscendo, allorchè un provvedimento ablatorio fosse annullato con
effetto ex tunc e la posizione soggettiva affievolità riprendesse
l'originaria consistenza di diritto soggettivo, la tutela di cui
all'art. 2043 cc.
Con la tesi del diritto affievolito, trovavano dunque tutela gli interessi legittimi di carattere oppositivo mentre rimanevano privi di qualsivoglia tutela giuridica di carattere risarcitorio gli interessi di natura pretensiva.
Con
l'art. 13 della L. n. 142 del 1992, un primo fondamentale passo in
direzione della risarcibilità degli interesi legittimi pretensivi è
stato effettuato, in ottemperanza alle indicazioni del Legislatore
comunitario, sancendo la risarcibilità degli interessi legittimi
pretensivi derivanti dalla violazione di normativa comunitaria in
materia di appalti di servizi e forniture, previo annullamento del
provvedimento illegittimo. La domanda doveva essere promossa dinanzi al
GO.
Tale
disposizione è, successivamente, implicitamente confluita nell'alveo
degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998 che, nel devolvere alla
giurisdizione esclusiva del GA le materie dell'urbanistica e dei
servizi pubblici affidava alla cognizione del GA anche le questioni
risarcitorie conseguenti tra le quali rientravano anche quelle di cui
all'art. 13 della L. n. 142 del 1992 abrogato. Si era, peraltro,
opinato che, attraverso la concentrazione della tutela risarcitoria
dinanzi al plesso giurisdizionale titolare della tutela impugnatoria
nelle materie di giurisdizione esclusiva, si era inteso generalizzare,
nell'ambito di tali materie, la risacibilità dell'interesse legittimo
precedentemente riconosciuta solo in via d'eccezione.
Sempre sulla via
del risarcimento dell'interesse legittimo, deve, poi, segnalarsi quanto
previsto dall'art. 17 della L. n. 59 del 1997 che delegava il Governo a
prevedere forme di indennizzo da ritardo nella conclusione del
procedimento amministrativo.
Entro
tale cornice normativa e di giurisprudenza, le Sezioni Unite della
Suprema Corte, con la sentenza n. 500 del 1999 , nel ripercorrere
l'evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa alla questione del
risarcimento del danno conseguente ad illecito aquliano, hanno
osservato come il danno ingiusto di cui all'art. 2043 cc non possa
essere confinato all'interno della lesione di un diritto soggettivo ma
debba individuarsi nella lesione di un qualsivoglia interesse giuridico
meritevole di tutela ad un bene della vita, con la sola esclusione
degli interessi di fatto. In tal senso, la clausola va intesa come
generale e rinviante all'opera individuatrice del Giudice il quale
dovrà comparare la meritevolezza dell'attività lesiva con la rilevanza
dell'interesse pregiudicato. Essa, dunque, non va interpretata come
clausola di rinvio alle posizioni giuridiche già tutelate
dall'ordinamento giuridico ma come clausola aperta suscettibile di
comprendere nel suo alveo ogni posizione di interesse ad un bene della
vita.
Così ricostruita la fattispecie della responsabilità aquiliana, la Suprema Corte ha interpetato la situazione giuridica di interesse legittimo come aspirazione ad un bene sostanziale della vita (prendendo le distanze, così, da tutte le teorie amministrativistiche che avevano ricostruito ll'interesse le gittimo come situazione giuridica occasionalmente protetta ovvero come interesse alla legittimità dell'azione amministrativa ovvero come posizione giuridica legittimante al ricorso giudiziale o giustiziale); è chiaro, peraltro, che il confine tra il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo e quello derivante da lesione di un diritto soggettivo diventa, in tal modo, sfumato così come sfumata diventa la differenza sostanziale tra la situazione giuridica del diritto soggettivo e quella dell'interesse legittimo che, peraltro, alla luce di tale diversa ricostruzione della posizione di interesse legittimo, costituiscono situazioni soggettive sovente concorrenti.
In definitiva il
risarcimento del danno acquista, per via di tale ricostruzione
interpretativa, autonomia rispetto alla situazione giuridica
sostanziale incisa e perciò protetta. Ne consegue il superamento dei
dubbi di carattere processuale sulla possibilità di riconoscere il
risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo in quanto, a
prescindere dalla situazione giuridica concretamente incisa, quello al
risarcimento del danno è un autonomo diritto.
In tale
prospettiva, la distinzione tra interesse legittimo pretensivo ed
interesse oppositivo rileva non più come criterio per affermare o
negare la tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo ma come
criterio per stabilire, in punto di merito, se la domanda risarcitoria
sia fondata o meno in quanto l'ingiustizia del danno, secondo la
Suprema Corte, sussiste sempre in caso di interessi oppositivi mentre
va verificata, di volta in volta con giudizio prognostico sulla
spettanza del bene, in caso di interessi pretensivi.
Con
riferimento alla colpa, poi, la Suprema Corte ha negato che la stessa
possa essere considerata in re ipsa per l'illegittimità dell'agere
occorrendo verificare se l'apparato amministrativo abbia
coplessivamente violato le regole di correttezza, imparzialità e buona
amministrazione ( parte della dottrina ha, al riguardo, osservato, in
senso critico, come il vizio di illegittimità si concreti proprio nella
violazione di tali regole)
Con riferimento alla questione della giurisdizione in materia di
risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo, le SS.UU.
avevano chiarito come sussistesse la giurisdizione del G.O. salvi i
casi di giurisdizione esclusiva del G.A. L'art. 7 della L. n. 205 del
2000, riscrivendo il terzo comma della L. n. 1034 del 1971 ha, invece,
stabilito che il G.A, nell'ambito della sua giurisdizione generale di
legittimità, ha anche competenza sulle questioni risarcitorie.
Tale previsione ha resistito al vaglio di legittimità costituzionale della Consulta che, con la sentenza n. 204 del 2004, ha chiarito come il risarcimento del danno non costituisca un'autonoma materia devoluta alla competenza esclusiva del G.A. ma un ulteriore strumento di tutela dell'interesse legittimo a dsposizione del Giudice amministrativo.
Con
riferimento alla risarcibilità degli interessi legittimi, una questione
che vede, tutt'ora, contrapposte la giurisprudenza amministrativa e
quella della Suprema Corte, riguarda l'accessibilità della tutela
risarcitoria in caso d'omessa impugnativa del provvedimento lesivo
(problema noto sotto il nome di pregiudizialità amministrativa).
Secondo
la prevalente giurisprudenza amministrativa tale possibilità sarebbe da escludere
in quanto significherebbe, per il privato, eludere l'onere
d'impugnativa nel termine di decadenza e, in chiave sostanziale, in
quanto sarebbe irragionevole riconoscere un danno ingiusto prodotto da
un provvedimento esistente e inoppugnabile.
Per
la Suprema Corte, invece, la pregiudiziale amministrativa sarebbe da
escludere sicchè il privato potrebbe domandare il risarcimento del
danno determinato da provvedimento illegittimo non tempestivamente
impugnato nel termine di prescrizione ordinario; peraltro, secondo un'attenta versione di tale impostazione,
il risarcimento del danno andrebbe limitato, ai sensi dell'art. 1227,
2° comma a quei danni che non sarebbero stati eliminati dalla
tempestiva impugnativa.
Sgomberato
risulta, invece, il campo dal dubbio, affacciatosi nella giurisprudenza
di legittimità, che la giurisdizione sarebbe stata del GO ove il risarcimento
del danno non fosse stato chiesto unitamente all'annullamento del
provvedimento lesivo.
Argomenti correlati