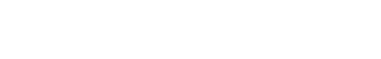La responsabilità della PA si può configurare come contrattuale,
allorchè derivi dalla violazione di specifici obblighi preesistenti (ad
esempio le obbligazioni contrattuali ma anche, secondo parte della
dottrina, gli obblighi di protezione derivanti da contatto
amministrativo qualificato) o come extracontrattuale allorchè derivi dalla violazione del principio del neminem laedere.
Posto il dato di fatto che la responsabilità della PA si riferisce sempre ad una condotta materiale o giuridica di un suo funzionario, si è discusso in dottrina se la responsabilità alla stessa ascrivibile sia diretta o indiretta secondo lo schema di cui all'art. 2049 cc. La teoria dell'immedesimazione organica tra l'autore dell'illecito e l'organo o l'ufficio nel quale risulta incardinato è stata elaborata per affermare la responsabilità diretta della PA (derivante dalla diretta imputazione degli atti del funzionario all'organo) anche al fine di risolvere il problema applicativo conseguente, in caso d'accoglimento della tesi della responsabilità indiretta, all'estensione in favore della PA del limite della responsabilità ai casi di dolo o colpa grave sancito a favore degli impiegati pubblici.
Tra le tesi che sono state avanzate, vi è d segnalare anche una teoria
intermedia per la quale la responsabilità della PA sarebbe indiretta ove attenga a meri comportamenti non
implicanti l'esercizio della funzione (si pensi, ad esempio, all'uso
delle autovetture di proprietà pubblica) e diretta ove l'atto o il
comportamento del funzionario sia riferibile all'esercizio della
funzione.
Le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione hanno, invece, chiarito che la responsabilità della PA è sempre diretta
salvo il caso in cui non sussista un nesso, neppure d'occasionalità,
tra l'azione produttiva di danno posta in essere dal pubblico
dipendente e la funzione dell'ufficio cui è assegnato o preposto. Si
esclude, dunque, la responsabilità della PA allorchè il dipendente
pubblico agisca per un fine esclusivamente privato.
Con specifico riferimento alla responsabilità extracontattuale della
PA, i presupposti sono quelli di cui all'art. 2043 cc e, cioè, la condotta antigiuridica, il danno ingiusto, il requisito psicologico della colpa o del dolo, l'evento dannoso il nesso di causalità tra condotta ed evento.
Per ciò che concerne la condotta antigiuridica deve trattarsi di un
comportamento posto in essere in violazione di norme di comportamento
e, quindi, stante il presupposto dell'illecita violazione della sfera
giuridica del soggetto passivo dell'illecito, in assenza di cause di giustificazione.
Con specifico riferimento alla PA, poi, è ulteriormente necessario che la condotta sia riferibile, almeno a titolo d'occasionalità necessaria,
all'esercizio dell'attività di pubblico interesse di competenza
dell'autore dell'illecito (come già visto, deve, dunque, escludersi la
responsabilità della PA per fatti o atti posti in essere dal pubblico
dipendente per fini esclusivamente personali).
Il danno ingiusto si configura come lesione di un interesse ad un bene della vita,
giuridicamente riconosciuto e prevalente, sulla base della valutazione
giudiziale, rispetto agli interessi (anche pubblicistici) sottesi
all'attività lesiva. La giurisprudenza ha progressivamente dilatato
l'area del danno ingiusto, partendo dai diritti assoluti, estendendo la
tutela alla lesione dei diritti di credito e, successivamente alla
sentenza n. 500 del 1999, comprendendo, nell'alveo della tutela
aquiliana, anche le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione di interessi legittimi, sul rilievo che la clausola generale di cui all'art. 2043 cc "danno ingiusto" non si riferirebbe a situazioni soggettive già tutelate da norme di relazione preesistenti ma sarebbe una clausola aperta
al riconoscimento di ogni situazione di interesse ad un bene della vita
che risulti meritevole di protezione rispetto all'attività
pregiudizievole sulla base di una valutazione da effettuarsi case by
case.
Ai fini dell'integrazione dei presupposti della responsabilità
extracontrattuale della PA è, inoltre, necessario il requisito della colpa o del dolo;
la giurisprudenza ha ritenuto, in via presuntiva, la presenza di tali
requisiti psicologici in ogni caso in cui sia violata, da parte della
PA, una norma giuridica concernente l'esercizio del potere e della
funzione.
Infine, ai fini della configurazione della responsabilità della PA, vi è la necessità del verificarsi di un evento dannoso e la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e l'evento dannoso.
I danni patrimoniali e morali subiti dal
destinatario della condotta antigiuridica sono risarcibili, cioè, solo
allorchè siano conseguenza della condotta medesima. In tale prospettiva
è necessario che la condotta sia condizione, sia del verificarsi
dell'evento lesivo, sia delle relative conseguenze pregiudizievoli. E'
altresì necessario che i danni siano prevedibili, al momento della
commissione dell'illecito, come conseguenza della condotta
antigiuridica posta in essere. Ai sensi dell'art. 1223 cc,
inoltre, sarebbero risarcibili solo i danni che si configurano come
conseguenza diretta della condotta antigiuridica ma, secondo quanto
chiarito dalla giurisprudenza, debbono rienersi risarcibili anche i
danni che si configurano come conseguenza indiretta ma normalmente
riconducibili a quel tipo di condotta. Alla luce della recente
definitiva acquisizione della risarcibilità dei danni conseguenti ad attività provvedimentale illegittima, particolare rilievo, ai fini della commisurazione del danno risarcibile, è destinata a rivestire la clausola di cui all'art. 1227 cc,
secondo comma a mente della quale il danneggiato non può esigere danni
che un suo diligente comportamento avrebbe evitato. Tale clausola è
destinata a trovare applicazione in tutti quei casi in cui il privato
domandi il risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo senza curare la preventiva impugnativa del provvedimento lesivo.
Al riguardo la Suprema Corte ha, con orientamento granitico, sostenuto
l'obbligo, per il GA, di conoscere della relativa controversia senza
poter opporre la pregiudiziale amministrativa e, cioè,
l'improcedibilità della domanda di risarcimento in difetto di un
preventivo annullamento del provvedimento lesivo. E, tuttavia, in
difetto di preventiva impugnativa, seguendo le indicazioni della
Suprema Corte, il danno risarcibile dovrà limitarsi a quelle
conseguenze che non sarebbero state evitate dall'impugnativa tempestiva
del provvedimento lesivo, in applicazione del principio di cui all'art.
1227 cc, secondo comma.
A
conclusione di questa breve ricognizione degli istituti connessi alla
responsabilità extracontrattuale della PA, deve sottolinearsi come si
reputino applicabili, sia pure con dei temperamenti, la presunzione di
responsabilità di cui all'art. 2050 cc per esercizio di attività pericolose
(al riguardo sono state superate le tesi che ritenevano
l'inpallicabilità di detta presunzione per la ritenuta incompatibilità
con il principio della presunzione di legittimità dell'attività
amministrativa non riferendosi detta presunzione all'attività
materiale, nonchè l'obiezione secondo cui l'art- 2050 sarebbe
riferibile solo alle attività private e non a quelle pubbliche che
perseguono gli interessi della collettività in quanto tale esclusione
non trova riscontro nel tenore della norma) e la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 cc,
sia pure con talune significative attenuanti derivanti dall'estensione
dei beni custoditi (al riguardo la giurisprudenza più recente di
legittimità sembra allontanarsi dall'orientamento stratificato secondo
cui l'estensione dei beni in custodia sarebbe, di per sè, suscettibile
di escludere l'applicabilità dell'art. 2051 cc - residuando la
possibilità di dimostrare la ricorrenza delle situazioni sintomatiche
dell'insidia e del trabocchetto - dovendo, al riguardo, essere
effettuata una valutazione case by case.
Argomenti correlati